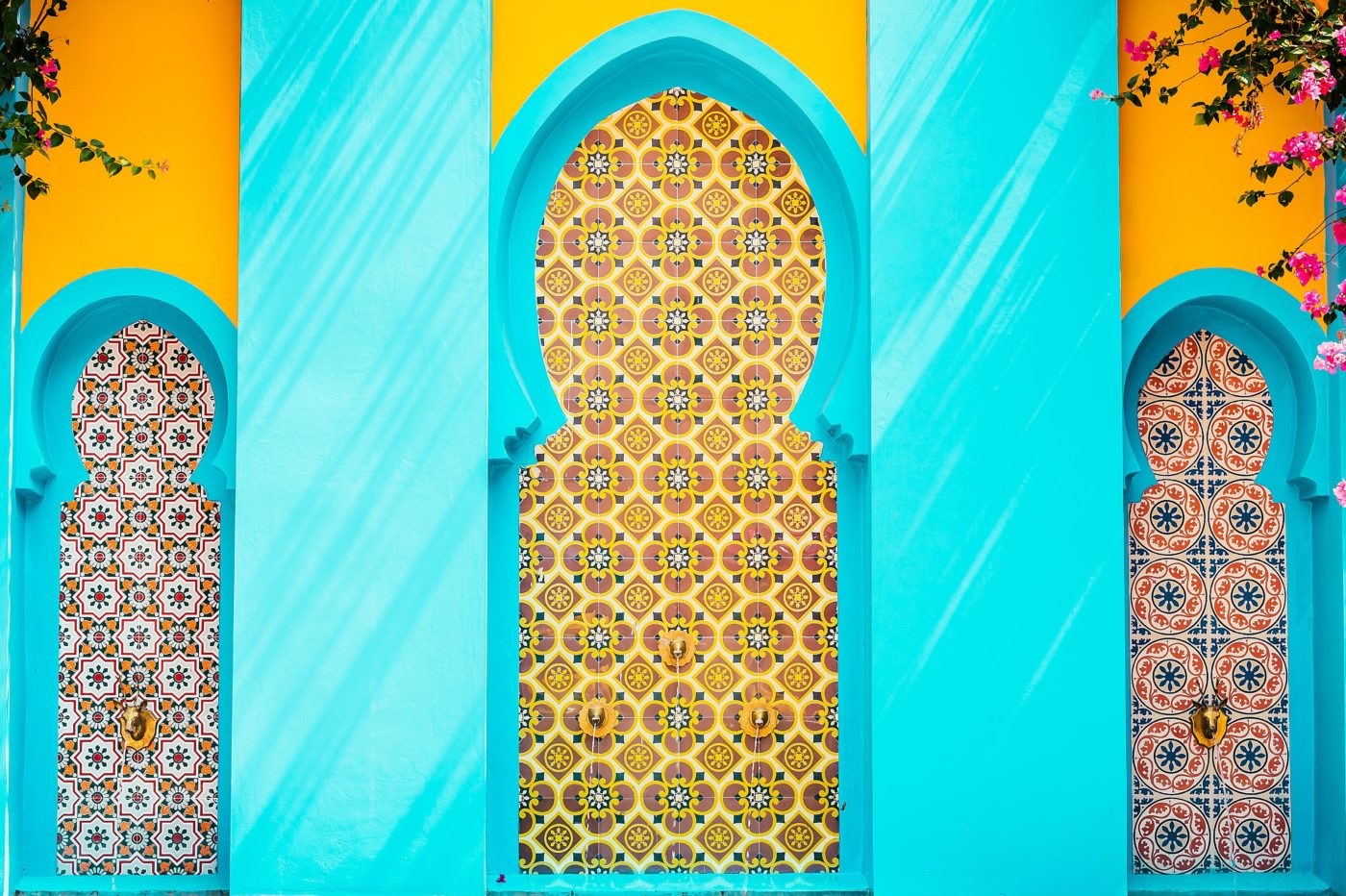Per leggere o scaricare la traduzione del racconto in PDF, clicca qui.
Kaouther Adimi
IL SESTO UOVO
Traduzione a cura di Margaret Petrarca

© Il diritto d’autore di questa traduzione è protetto dall’art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dall’art.7.
Kaouther Adimi è nata nel 1986 ad Algeri e nel 2009 si è trasferita a Parigi, dove risiede tuttora. Ha pubblicato tre romanzi, due dei quali tradotti in italiano. Il primo è Des ballerines de papicha (Éditions Barzakh, 2011), pubblicato poi da Actes Sud con il titolo L’Envers des autres. L’opera ha vinto il Prix littéraire de la Vocation ed è stata tradotta in italiano come Le ballerine di Papicha (il Sirente, 2017 traduzione di Federica Pistono). Il secondo è Des pierres dans ma poche (Éditions Barzakh, 2015 e Éditions Seuil, 2016). L’ultimo è Nos richesses (Éditions Barzakh e Éditions Seuil, 2017), tradotto in italiano come La libreria della rue Charras (L’orma Editore, 2018, traduzione di Francesca Bononi), che ha vinto il Prix Renaudot des lycéens, la Liste Goncourt – le Choix de l’Italie e il Prix du Style.
Il racconto Le sixième œuf è stato pubblicato all’interno del volume Alger, quand la ville dort… (Éditions Barzakh, 2010).
Ringrazio la casa editrice algerina Éditions Barzakh per avermi dato la possibilità di pubblicare la traduzione del racconto sul mio sito.
Il sesto uovo
Sono pulito. Vesto solo di bianco. Quello strano fetore è sparito. Non c’è niente intorno a me. Solo un materasso su cui dormire. Non ci sono quadri appesi ai muri né finestre che illuminano la stanza. Sono solo con i miei pensieri e i miei crimini. Le giornate vengono scandite da due cose: il richiamo alla preghiera del muezzin e le visite di un gentile infermiere che mi porta pillole e pasti.
Non riesco a mangiare da solo: ho le braccia legate dietro la schiena.
*
È andata com’è andata. Cosa volete che vi dica? Sono solo un militare. Un essere inventato di sana pianta dalla Grande Istituzione per difendere il paese in quei tempi bui. Adesso mi chiedono come abbia potuto. Non capite: erano altri tempi. Ricordate! Dopo quell’autobus preso a sassate il governo ha deciso di rispondere utilizzando tutti i mezzi che aveva a disposizione. Ha distribuito passaporti, visti e biglietti aerei. Tutti i canali della radio e della televisione trasmettevano canti patriottici. I bambini disegnavano bandiere sui muri degli edifici pubblici. Le ragazzine avevano l’autorizzazione per invadere gli stadi.
Così, il Ministero della difesa ha messo in piedi una forza speciale d’intervento. Ne facevo parte. Lo scorso novembre mi hanno mandato in missione segreta nella capitale. Stava per svolgersi l’ultimo combattimento e noi dovevamo assolutamente vincerlo.
Mi hanno paracadutato, una notte, ad Algeri. In piena guerra. Per distruggere il nemico e morire in battaglia. Capite? Non era previsto che sopravvivessi! Prima? Non lo so più. Ho qualche vago ricordo incollato al subconscio. Immagini sfocate di esseri umani, di colori, qualche suono. Non molto, insomma. Ah sì, c’era una vecchia signora che mi portava da mangiare. Non so cosa ne sia stato di lei. Il liceo? Forse. Muri bianchi e blu, qualche tavolo di legno, vecchie sedie. Sapete, in Algeria i licei si assomigliano tutti. E poi, sono sulla trentina, sono cose del passato, queste. Ma non ho dimenticato niente, della guerra. Niente…
Faceva freddo. È così che me la ricordo: un freddo pungente che toglieva la sensibilità alle dita dei piedi. Mentre aspettavo l’inizio del conflitto sbattevo la punta dello stivale destro contro il tallone dello stivale sinistro nella vana speranza che quel gesto finisse per riscaldare i miei piedi martoriati. Per fortuna ha iniziato a nevicare e il tempo si è addolcito. Fiocchi grossi e fitti hanno ricoperto di una sottile pellicola la Place Maurice Audin. Mi sono seduto sui gradini davanti all’entrata dell’università. È lì che il combattimento doveva svolgersi. Dove le nostre due armate dovevano affrontarsi. Ed è su di me che incombeva il compito di fare la differenza, di portare il mio paese in trionfo, di ridicolizzare il nemico, di rivestire Algeri di verde e di rosso. I suoi colori originari.
Non c’era un cane fuori. Tutti gli algerini, dal neonato appena sbarcato in questo mondo alla nonnetta più rimbambita, erano a casa loro con gli occhi appiccicati allo schermo. Per la prima volta in vita mia Algeri si offriva solo ai miei occhi, sola e cupa. Conosco bene la città bianca. Ci sono nato e ci ho vissuto fino ai miei sedici anni. Rue d’Isly. Un bell’appartamento. Piccolo piccolo, ma abbastanza grande per me, i miei genitori e la mia sorellina. Quando mia nonna è venuta a vivere con noi, dopo la morte di mio nonno, si stava un po’ stretti ma ci siamo arrangiati. In ogni caso ci volevamo bene e non ci importava di stare sempre incollati l’uno all’altro. Ogni venerdì mattina avevo l’incarico di fare un po’ di spesa per la casa. Mia sorella mi accompagnava. Era la nostra grande uscita settimanale. Oh, una spesa da quattro soldi, la nostra. Quattro panini belli caldi, qualche porzione di formaggio che il venditore faceva scivolare in una busta di plastica trasparente, una bottiglia di gazouz, una busta di latte che mia sorella era incaricata di portare con precauzione e, per finire, sei uova. Non ho mai capito perché mia madre volesse che comprassimo sei uova. Sei uova quando noi eravamo cinque. Per chi è il sesto uovo, mamma?, le chiedevo ogni venerdì, come un piccolo gioco settimanale, un vecchio ritornello abitudinario e rassicurante. Lo mangia la città, mi rispondeva. Scherzava, ovviamente. Comunque, mi sono spesso domandato dove si trovasse la bocca di Algeri. Quest’ultima mi appariva allora come un luogo d’incanto e meraviglia.
Molto tempo dopo, ho scoperto l’altra faccia di questa città, divoratrice di uova. L’adolescenza mi ha scaraventato verso sera in bar squattrinati, in cabaret danzanti, in quei vicoletti pericolosi in cui i poliziotti hanno il manganello facile. Ho dovuto di nuovo conquistare questa città che occupavo come un proprietario e di cui non ero che un semplice inquilino cieco e sordo. Algeri non era più la città allegra. Sapete, Algeri, di notte, è un vasto campo da gioco che io e miei compagni di allora esploravamo con gioia in compagnia di qualche gatto malandato. Abbiamo così sposato ogni dosso, ogni strada, ogni graffito di questa città. Fischiavamo alle rare ragazze che passavano, cantanti, puttane, ragazzine, mai suore… Abbiamo anche contribuito a sporcarla con i nostri rifiuti, a colorarla con pennarelli indelebili, a farla diventare più viva con le nostre canzoni provocatorie. E, quando, nel cuore della notte, un vicino infuriato ci buttava sulle teste sfrontate una pentolata d’acqua fredda per farci stare zitti, ci stringevamo sotto un portico qualsiasi mettendoci a urlare tutti gli insulti che avevamo in mente. E poi noi… ma chi se lo ricorda quello che facevamo. Sono cose di tanto tempo fa, queste…
Ho quindi aspettato nella città, che era rotta così come solo un giocattolo può essere. Stupidamente. Ho aspettato il momento in cui sarei diventato un eroe, in cui avrei vendicato i nostri morti. Alla fine ho acceso l’ultima sigaretta che mi ero conservato in caso di sconfitta. Come un piccolo piacere che mi sarei regalato prima di morire. Pazienza. Ci si batte davvero solo una volta.
Ha iniziato a nevicare. E il tempo si è addolcito. Sono caduti grossi fiocchi di neve, ricoprendo poco a poco Place Maurice Audin e i gradini dell’università dove mi ero seduto, ma credo di avervelo già detto… Ho qualche problema con la neve, sapete. La trovo ipocrita. Sembra cotone, ma alla fine è solo acqua. Perché allora fa finta di essere cotone? Non mi piace quando le cose non sono quello che sembrano. Prendete Algeri. Durante il giorno conserva la forma di una macchina ben oliata in cui si affrettano curiosi, famiglie e studenti. Dà l’impressione di un operaio onesto che si sveglia presto la mattina, in piena forma, e che si affatica poco a poco con il passare delle ore per addormentarsi solo quando l’ultimo buon algerino è rientrato a casa. Ed è in quel momento, quando quel buon algerino torna a casa, che la città si rimbocca le maniche, ingoia le uova e vomita barboni, drogati, futuri harragas, prostitute, cantanti di pianobar, giornalisti e poliziotti da quattro soldi. È uguale, per la neve. Ha l’aria fragile fragile, così bianca bianca, bella bella, ma vi fa fuori un uomo in men che non si dica. Diversi compagni sono morti congelati. Non ci eravamo abituati! Siamo cresciuti sotto il solleone, quindi la neve all’inizio era soprattutto un gioco. Ci ha fatto quasi dimenticare la guerra. Mi ricordo che con i compagni costruivamo pupazzi di neve vicino a enormi palme. Era proprio un bel vedere. Quando le prime pallottole hanno iniziato a fischiare, abbiamo dovuto abbandonare i giochi e rifugiarci nella moschea più vicina. Ne abbiamo approfittato per pregare. È salita a tutti la depressione addosso. Le preghiere fatte così, in fretta e furia, fanno pensare più alla morte che ad altro. Io mi sono messo in un angolo e ho detto: Dio, mettiamoci d’accordo: tu salvi me e io salvo tutti gli altri. Faccio saltare in aria questi bamboccioni in rosso e nero, ridipingo la città intera di rosso e verde. Salvami e io salverò Algeri.
Ci siamo salvati. In extremis. Ci hanno bendato la testa e ci hanno rimandato in battaglia dopo averci concesso una serata libera. La mia ragazza ne ha approfittato per venire a trovarmi. Che stronza! Ha fatto una scenata perché le avevo dato buca a un appuntamento. Dovevamo vederci per festeggiare un compleanno, andare a pesca, sposarci… non ricordo più. Non l’avevo vista da un pezzo. Era prima che la città cadesse nelle mani del nemico. Prima che le bandiere algerine fiorissero su tutti i muri della città in segno di resistenza. Prima di tutte queste stronzate che nessuno si aspettava. Comunque, me ne ha dette di tutti i colori, e davanti a tutti gli altri per di più! I compagni si erano piegati in due dalle risate. Non so cosa mi ha fermato dal piantarle una pallottola nello stomaco. La paura di non averne più per il nemico, immagino. Non capisco le donne. Facciamo di tutto per mettere un po’ di pace nel mondo, viviamo circondati dalla povertà, ammazziamo gente per loro, e appena ci dimentichiamo qualcosa tirano fuori l’arsenale, e quello pesante! Se non sono riuscito a vederla è perché i nemici ci sono saltati addosso all’alba. Anche se ne ho uccisi tre completamente da solo! Ho ricevuto una medaglia dal generale. Sono comunque un po’ triste per la vecchia signora che si occupava dei pasti: non è sopravvissuta, poverina… Rivedo ancora il suo vecchio corpo congelato nella neve. Mi guardava con gli occhi fuori dalle orbite, come se non riuscisse a capacitarsene. Mi ha fatto gelare il sangue.
Avrei dovuto prendere più sigarette, ma non ho osato. Quella che ho fumato sui gradini dell’università l’ho rubata a Hocine. Chi è Hocine? Era il mio amico, mio fratello. Siamo cresciuti insieme. Da piccoli ci precipitavamo giù per Rue Didouche Mourad, con addosso un paio di pantaloncini rammendati e ai piedi vecchie ciabatte troppo grandi, per comprare arachidi e gelati. Erano tempi d’oro. Quando sono entrato nell’esercito e ho lasciato Algeri, Hocine mi ha seguito. Ci assomigliavamo molto, al punto che a volte ci scambiavano per gemelli. Una notte… non ricordo quale, non importa, chi se ne frega delle date, comunque, una notte, prima di tornare ad Algeri, ho provato a chiamare i miei genitori. Volevo sentire la loro voce un’ultima volta prima di andare in battaglia. Sono vecchi adesso… Ho parlato al telefono con mia madre. Piangeva, diceva di chiamare la polizia, mi supplicava di tornare. Ho cercato di spiegarle che il dovere veniva prima di tutto, ma una bomba è esplosa in lontananza e ho dovuto riagganciare. Hocine era stato colpito al cuore, pisciava sangue. Sono rimasto accanto a lui tutta la notte, per asciugargli la fronte che bruciava di sudore. Poverino, mi faceva tanta pena. Ho sentito il mio amico, mio fratello, il mio compagno delirare per tutta la notte. Pensava che fosse tornato bambino, che sua madre fosse lì. Non si rendeva conto che c’erano bombe che esplodevano da tutte le parti. Mi ha addirittura tirato per la manica per dirmi che voleva abbandonare tutto, ma che non ci riusciva. Che sognava di darsela a gambe, di ritornare ad Algeri, di rivedere per l’ultima volta Rue Didouche Mourad. Gli ho detto di stare zitto, altrimenti il generale lo avrebbe sentito. Non deve credere che pensiamo di disertare. Vengono fucilati, i disertori. A prescindere dallo schieramento, vengono fucilati.
All’alba era morto. Ho pianto, non sapevo come fare senza di lui. Allora ho preso l’unica cosa che possedeva: una sigaretta che conservava per la fine della guerra.
Cos’è successo dopo la sigaretta? La fine del mondo. Non ci ho capito molto, all’inizio. Migliaia di persone hanno invaso Place Audin. Le luci esplodevano ovunque nel cielo scuro, illuminando per qualche istante la città addormentata, dandole riflessi verdi e rossi. Piena di vita, Algeri sembrava voler allontanare i limiti della notte, illuminare il cielo di un sole improbabile, far dimenticare ai suoi abitanti l’oscurità del suo soffitto. Venivano sparati fuochi d’artificio, gridati youyou, le radio urlavano l’inno nazionale, i giovani appendevano le bandiere algerine ai muri, le bambine urlavano strappandosi i vestiti di dosso. I vecchi piangevano. E c’erano da tutte le parti persone che si abbracciavano. Il fumo ci avvolgeva, ma non al punto da non distinguere i giusti dai traditori. E già apparivano le armi. Era arrivato il momento, per me, di addentrarmi nella città, di seguire il cammino tortuoso e di andare fino al nucleo del nemico, fino alla sua ultima trincea. Lì dove il sesto uovo di ogni famiglia veniva inghiottito. Era arrivato il momento di tagliare la testa del nemico per impedirgli di tornare a sporcare i muri di Algeri. Anche se annunciavano ovunque la nostra vittoria, io sapevo che quei porci si nascondevano tra le nostre mura. Bisognava stanarli.
Ho corso verso Bab El Oued, sì, ho corso a perdifiato. Nessuno prima di me si era fiondato così su quella strada, nessuno! Dietro la curva di una viuzza mi sono imbattuto in un nemico, in tenuta da combattimento. Il cuore mi è salito in gola, ho premuto il grilletto, ma l’ho mancato. Lui non è fuggito e mi ha addirittura sorriso. Aveva i capelli lunghi con enormi occhi verdi in un viso tondo. Per un secondo ho pensato a Malika, la mia sorellina. Probabilmente a causa del colore degli occhi e del sorriso. Malika aveva quel modo di sorridere, come un neonato… Mi faceva paura talmente era bello. Spuntava senza preavviso, il sorriso voglio dire, e ne animava spontaneamente il viso, si estendeva, formando delle crepe nelle guance, scavandole, raddrizzandole, illuminando gli occhi, arricciando il naso. Non gliel’ho mai detto. Un uomo, un vero uomo, non parla di queste cose, parla di ragazze, di armi, di permesso di soggiorno. I sorrisi, gli occhi, tutta questa roba, non siamo tenuti a conoscerla. In quel momento la mia mano si è rinsaldata e sono riuscito a sparare. Se non l’avessi ucciso, forse avrebbe violentato e ammazzato mia sorella. Mi vergogno a dirlo, ma l’odore della polvere mi ha fatto vomitare.
Non so che ora fosse! Credete che abbia pensato a guardare l’orologio? Era buio. Aspettate, sto ricordando, saranno state le 22, ho intravisto l’orologio passando davanti alla Posta Centrale tutta illuminata. Dopo… credo di essermi nascosto per qualche secondo nell’atrio di un palazzo. Dovevo riprendermi, c’erano solo buio e un silenzio opprimente. E un odore di cadaveri e sangue. Ho visto una volta in tivù dei ragazzi che erano andati in guerra. Dicevano che anche molti anni dopo il ritorno alla vita civile, continuavano a sentire l’odore di sangue sulle mani. Sono rimasto nell’atrio del palazzo, ho caricato la pistola e ho aspettato che arrivassero. Come sapevo che sarebbero arrivati? Un bravo soldato lo sa sempre.
Ho sentito diversi rumori di passi. Avevo le ore contate. Sarei morto in battaglia, ma non mi sono mosso. Non c’era nessun posto dove andare. Non si può fuggire da Algeri, sapete, non importa dove si vada, lei è lì che si impone nella vostra testa, nella vostra vita. Come la peste o la malaria. Una porta è saltata in aria. Mi sono piovute addosso schegge di ferro e legno, sono spuntati fuori strani animali. Ho nascosto il viso con le mani per non farmi ferire dai loro musi. Luci bianche e gialle hanno cercato di illuminare il mio nascondiglio. Sono entrati dei militari e degli strani uomini vestiti di bianco. Dei nemici? Non lo so. Mi hanno preso. Mi hanno sbattuto contro il muro e mi hanno legato le mani prima di farmi un’iniezione. Ho urlato: BASTARDI. Ho provato a slegarmi, di ucciderne almeno uno. Non poterli strangolare mi stava facendo impazzire.
Ho fallito. Non sono riuscito a uccidere tutti i nemici. Devo morire.
*
Non lo so. Smettetela con queste domande! Non volevo andare in guerra. Ci sono andato per dovere, perché dovevo difendere la patria dai nemici. Che vuol dire quali nemici? Quelli che volevano conquistare il paese! Perché? Per via dell’autobus, del calcio, del sesto uovo… tutta questa roba, insomma! Cazzo, chiedete al generale, io non lo so. No, non ho diciassette anni, sono un militare! Ho medaglie che lo dimostrano. La mia famiglia? Vive ad Algeri. No, non ho ucciso nessuno. Cioè sì, i nemici. Mia nonna? Non ce l’ho. Ah! La vecchia signora della mensa, era gentile. Poverina, morta per colpa di una bomba. L’ho rimpianta molto. Hocine? No, non sono io, è mio fratello, il mio amico, è morto, poverino. La mia sorellina? Starà dormendo, è presto, sapete. Ma non vi preoccupate, il nemico non le farà niente, me ne sono occupato io.
Se voglio dormire? Non posso, è venerdì, devo portare il sesto uovo alla città, altrimenti ci inghiottirà tutti.