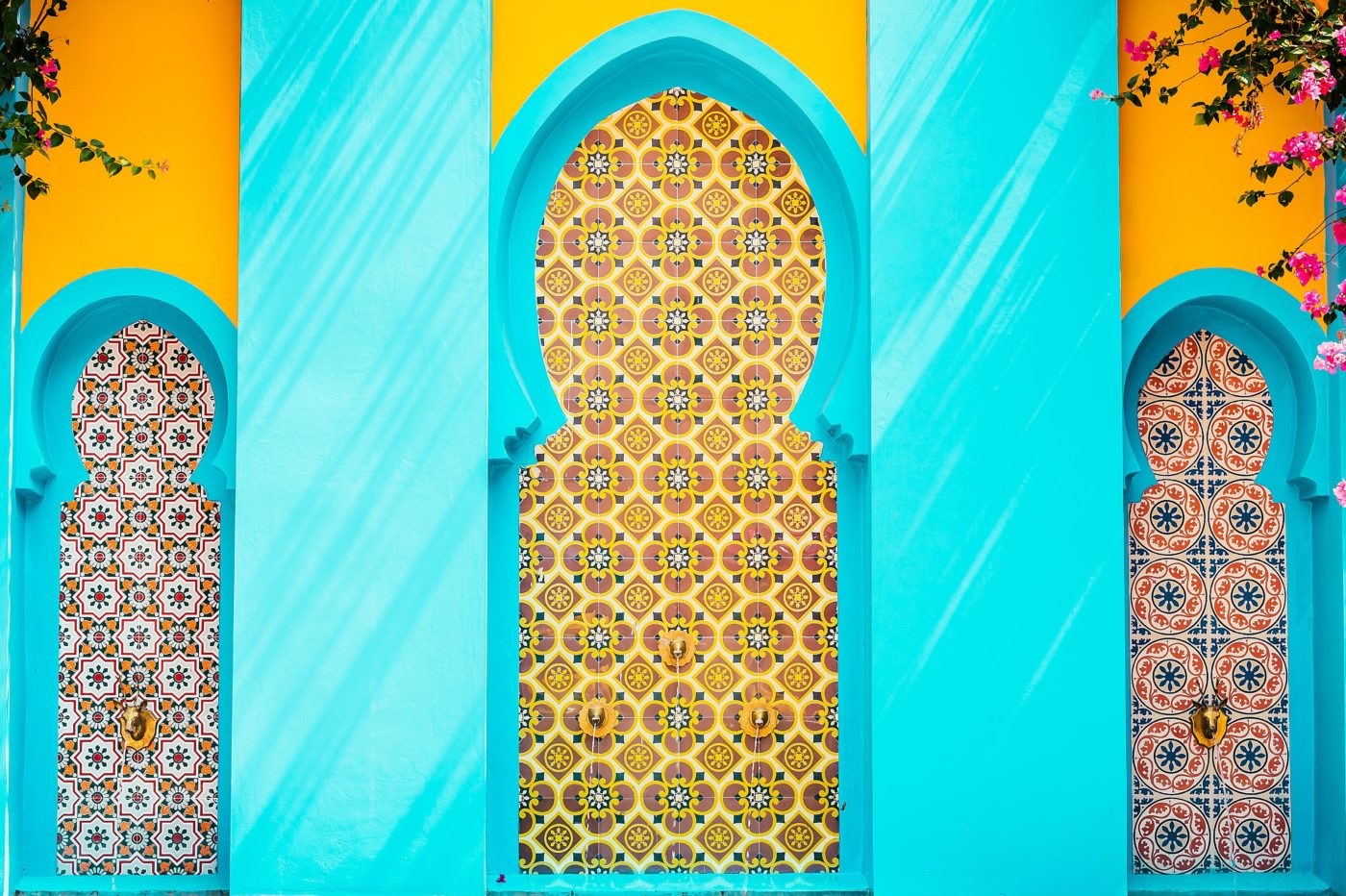Traduire l’autre, pratiques interlinguistiques et écritures ethnographiques è un convegno internazionale tenutosi a Forlì il 9 e il 10 novembre 2017. Il convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, dal Do.Ri.F. e dalla SIT – Società Italiana di Traduttologia, coordinato da Antonio Lavieri e Danielle Londei. Il programma è stato distribuito su quattro assi[1] per mettere in luce la dimensione interdisciplinare che la traduttologia condivide con l’antropologia e la scrittura etnografica. Tutti gli atti di convegno verranno pubblicati entro la fine del 2018 all’interno di un unico volume.
Traduire l’autre, pratiques interlinguistiques et écritures ethnographiques è un convegno internazionale tenutosi a Forlì il 9 e il 10 novembre 2017. Il convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, dal Do.Ri.F. e dalla SIT – Società Italiana di Traduttologia, coordinato da Antonio Lavieri e Danielle Londei. Il programma è stato distribuito su quattro assi[1] per mettere in luce la dimensione interdisciplinare che la traduttologia condivide con l’antropologia e la scrittura etnografica. Tutti gli atti di convegno verranno pubblicati entro la fine del 2018 all’interno di un unico volume.
L’incontro con l’Altro prevede sempre un certo grado di interdisciplinarietà. Alcuni incontri, però, sono più interdisciplinari di altri. A volte, addirittura, mondi apparentemente distanti si incontrano e i confini tra gli uni e gli altri diventano intellegibili. Questo è il caso dell’antropologia e della traduttologia.
L’antropologia, trattando lo studio dell’uomo, è per eccellenza la scienza che si occupa di investigare e conoscere l’Altro. Per lungo tempo la figura dell’antropologo è stata associata a spedizioni in terre lontane, in cui l’incontro con l’Altro richiedeva un enorme sforzo di comprensione e di astensione di giudizio. L’incontro con popolazioni Dogon, Kaluli e molte altre era mediato spesso, se non sempre, da interpreti locali che traducevano per gli antropologi. Questi ultimi, a loro volta, traducevano ciò che veniva loro detto, ciò che vedevano, ciò a cui partecipavano e, spesso, ciò che interpretavano, in appunti che poi sarebbero diventati libri scientifici, dando vita a quella che viene chiamata scrittura etnografica.
La traduttologia, invece, si occupa di studiare la traduzione. La traduzione è, anch’essa, sebbene non in modo empirico, un incontro con l’Altro. Il traduttore cerca di interpretare l’opera letteraria prima di tradurla, per capirla fino in fondo e dare così vita a un testo di arrivo che possa veicolare un messaggio e uno stile “fedeli” a quelli del testo di partenza. Più la cultura di partenza sarà diversa da quella di arrivo, più il lavoro del traduttore sarà complicato, diventando egli stesso antropologo.
Grazie ai diversi movimenti migratori di questi ultimi anni, il mestiere dell’antropologo e quello del traduttore non sono mai stati così vicini. Il diverso e l’uguale non solo condividono lo stesso spazio geografico, ma si uniscono dando vita a nuove forme sociali e letterarie. L’antropologo deve attuare una traduzione intersemiotica di queste nuove realtà e, allo stesso tempo, il traduttore deve capirle prima di poter realizzare una traduzione interlinguistica di quella che viene definita letteratura della migrazione.
Affinità tra traduttore ed etnologo
Etnologo e traduttore sembrano condividere la stessa forma mentis. Entrambi sono proiettati verso l’Altro e, nello sforzo di capirlo, cercano di oltrepassare le proprie categorie mentali diventando testimoni e narratori di ciò che è diverso da loro. Queste affinità, che scaturiscono da diversi fattori implicitamente esposti durante tutto il convegno, sono state messe in luce in modo particolare da Hélène Buzelin e Francis Affergan. La prima espone in maniera diretta il rapporto che intercorre tra le due professioni partendo dagli albori dei Translation Studies. È proprio con la nascita di questi studi che emerge la figura del traduttologo, che non si occupa di spiegare come un testo andrebbe tradotto, bensì di analizzare il lavoro dei traduttori: prende quindi come oggetto di studio traduzioni già esistenti, analizzandole e descrivendole. Questa figura potrebbe essere paragonata a quella dell’etnologo, in quanto anch’egli deve, in maniera trasversale, scendere sul campo. Infatti, il traduttologo si occupa di analizzare le traduzioni esistenti di determinate opere al fine di studiarne i principi, i metodi e le tecniche. Egli, quindi, si occupa da un lato della ricerca sul campo (che nel suo caso sono le opere tradotte) e, dall’altro, del discorso traduttologico sulle pratiche adottate. Forte di questa propensione, non è un caso se la traduttologia ha espanso le sue ricerche avvicinandosi agli studi postcoloniali e all’antropologia ed etnografia. Grazie a questa collaborazione, la traduttologia non studia più soltanto il testo tradotto, ma si interessa anche a chi produce i testi, in particolar modo alle istituzioni che si occupano di pubblicare le traduzioni, dando ancora più importanza allo studio sul campo. Francis Affergan, invece, mette l’accento sulla questione dell’infedeltà, che, per lui, non riguarda solo il campo della traduzione, ma anche quello dell’etnologia. Per quanto riguarda la prima disciplina, il docente tiene a dimostrarci che la traduzione strictu sensu non esiste. Per farlo, pone come esempio una qualsiasi lingua indigena. Se volessimo tradurla correttamente, dovremmo capire come una determinata parola viene utilizzata dagli indigeni, non cosa la parola significhi, perché il nostro significato delle cose non corrisponde al loro. Dovremmo, quindi, andare al di là del nostro sistema per capire fino in fondo quella parola in modo da poterla tradurre in modo adeguato. Questo, però, è possibile? Secondo Francis Affergan, per riuscire a creare una traduzione corretta, bisognerebbe approcciarsi in modo diverso sia all’atto traduttivo che al testo di partenza. Il traduttore non dovrebbe avere come scopo ultimo quello di creare un testo di arrivo uguale all’originale. Al contrario, il testo di arrivo dovrebbe essere ricostruito in modo autonomo e sovrano dal traduttore, che ne diventa così autore. Il compito del traduttore diventa quello di scoprire la risonanza del testo di partenza e, in questo senso, se tradurre significa svegliare l’eco dell’originale, il traduttore deve lavorare sugli echi.
La “fedeltà”, intesa come riproduzione dell’originale, non è possibile neanche nel caso della seconda disciplina, l’etnologia, in quanto, secondo Malinowski, «Le sens ne s’épuise jamais dans ce qui est visé». L’etnologo, più che tradurre la lingua degli altri, traduce la sua in modo da riuscire a interpretare l’ostacolo dell’altra lingua. Quindi, tirando le somme, il traduttore e l’etnologo condividono la stessa sorte: quella di essere l’interprete fallito dell’Altro e di se stesso. Tradurre, infatti, per Francis Affergan, significa semplicemente accettare la perdita che si crea quando trasferiamo dei concetti da una lingua all’altra. Il traduttore e l’etnologo non fanno altro che tradurre questa perdita. Le conclusioni del docente algerino sono, forse, un po’ troppo pessimistiche. Eppure, è proprio all’interno delle perdite di cui lui parla che la creazione e l’innovazione prendono forma.
Il traduttore che diventa antropologo
Il traduttore deve confrontarsi con un testo che segue pensieri che non sempre gli appartengono. Deve, insomma, cercare di andare incontro all’Altro, cercando di non lasciar trasparire il proprio pensiero, la propria opinione, ma accogliendo quella altrui. In questo senso il traduttore è sempre un po’ antropologo. Gli stessi antropologi ci insegnano che per scoprire l’Altro non occorre andare in terre lontane, anzi, spesso la scoperta dell’Altro inizia proprio da quello che ci circonda. Inutile negare, però, che i primi antropologi che andavano a sondare il terreno a migliaia di chilometri lontano dalla propria terra natia, spesso in condizioni a cui non erano assolutamente abituati, emanano ancora oggi un fascino che è difficile eguagliare. Allo stesso modo, per me, la traduzione acquisisce un sapore molto più interessante quando viene realizzata tra lingue e culture apparentemente molto diverse tra loro. Il risultato finale sarà sempre più frizzante e innovativo rispetto a quello di una traduzione di un romanzo che rimbalza tra lingue e culture vicine. Il traduttore che traduce un romanzo distante dalla sua lingua e dalla sua cultura mi pare possa essere paragonato esattamente a quegli stessi antropologi che andavano in avanscoperta qualche tempo fa in terre lontane e insidiose. In questo modo astenere il proprio giudizio e lasciare una mente più aperta possibile per accogliere quello che è diverso diventano imprescindibili nel momento dell’atto traduttivo ed è così che il traduttore diventa un antropologo viaggiatore. La traduttrice Mathilde Fontanet ci ha parlato proprio della sua attività in quanto traduttrice di opere lontane dal suo sistema culturale svizzero. Tra queste ci sono i romanzi di Helene Cooper, scrittrice dalle origini liberiane, di cui ha tradotto The house of sugar beach (2008) e Madame President (2017). Il primo tratta della vita della stessa Helene Cooper, nata e cresciuta a Sugar Beach, in Liberia, Africa, e della sua fuga in America dopo il colpo di stato liberiano del 1980. Il secondo, invece, parla della storia di Ellen Johnson Sirleaf, leader del movimento di donne per la pace in Liberia, vincitrice del Premio Nobel per la pace 2011 e prima donna eletta come capo di Stato in Africa. Entrambi i romanzi trattano di tematiche politiche, in cui la figura femminile gioca un ruolo preponderante. Da un punto di vista linguistico, considerando l’alterità di questi due romanzi, la traduttrice ha optato per diverse strategie traduttive. I testi, scritti in creolo, presentano le caratteristiche tipiche di una “lingua meticcia”: la struttura di base è prevalentemente quella della lingua inglese, ma essa è minata da proverbi ed espressioni idiomatiche in creolo, dall’alternarsi di diverse lingue tradizionali e del discorso diretto e indiretto. L’inglese utilizzato, quindi, possiede un ritmo diverso da quello statunitense considerato standard, presentandosi soprattutto come una lingua orale. Per far fronte a tutto questo, Mathilde Fontanet ha deciso di arricchire la sua traduzione aggiungendo proverbi e sonorità, come rime e allitterazioni. La traduttrice, poi, per riuscire a dominare il testo, ha studiato le strategie traduttive di altri traduttori, al fine di poterli imitare quando necessario. Il risultato finale ha portato alla creazione di una nuova lingua, con effetti propri, che traggono ispirazione dal creolo francese e dal linguaggio familiare dell’Esagono. Mathilde Fontanet è dovuta scendere sul campo del testo, aprirsi a esso senza lasciarsi influenzare dalle sue categorie mentali. In questo modo ha superato i suoi giudizi, riuscendo a creare qualcosa di nuovo che possa trasmettere, forse infedelmente, l’alterità del testo di partenza.
L’antropologo che diventa traduttore
La relazione tra antropologia e traduzione non è univoca. Difatti, anche l’antropologo spesso diventa traduttore. Si tratta, nel suo caso, di una traduzione intersemiotica, in quanto egli traduce ciò che osserva e “scopre” di una determinata popolazione all’interno di un testo che può addirittura essere al margine tra lo scientifico e il letterario. Egli si cimenta, insomma, nella scrittura etnografica. Ci esplicita questo concetto l’antropologo e scrittore François Laplantine. Egli si è dedicato alla scrittura delle grandi città, come Tokyo e Pechino, esposte all’interno di Tokyo, Ville flottante (2010) e Une autre Chine (2012), libri a cavallo fra trattati antropologici e resoconti di viaggio. Mentre era in avanscoperta in questi luoghi, l’antropologo si è impegnato a scoprire immagini, sapori, odori, gesti e mimiche. Compiendo un atto di traduzione, lo scrittore ha trasformato questi effetti sociali in lingua scritta. Infatti, Tokyo e Pechino sono diventate un testo proprio a partire dalle sue scoperte sensoriali.
Egli afferma che, in generale, quando si compie un atto di scrittura etnografica, si deve fuggire dalle generalizzazioni. In particolare, quando si descrive una città, il ritmo della frase deve andare di pari passo con quello dell’urbe; soprattutto, esso deve rispettare l’andamento della camminata della popolazione che la abita. Ci dice, ad esempio, che il ritmo a Parigi è frettoloso, a Tokyo disteso e a San Paolo totalmente rilassato. Dopo essersi soffermato sulle differenze tra Tokyo e Pechino, François Laplatine ci spiega come ha trasformato le due città in letteratura, rispettando il loro ritmo intrinseco. La scrittura utilizzata per parlare di Tokyo, città senza un centro, non è lineare, bensì circolare. Mentre Pechino segue un ritmo, una pulsazione, irregolare, fatta di accelerazione e decelerazione. In questo caso l’antropologo ha posto l’accento, quindi, sul rapporto che la metropoli ha con la temporalità. Dal canto loro Lorella Sini e Marie-France Merger ci parlano di un altro etnografo che ha tradotto in opera divulgativa la sua considerazione sulle razze, ovvero Louis Figuier e le sue Races humaines (1872). Seguendo la scia della divulgazione, l’autore all’interno del testo si sofferma sulle caratteristiche della razza umana, realizzando un album di viaggio illustrato, steso seguendo un punto di vista antropologico ed etnologico. All’interno di Les races humaines, Louis Figuier delinea una per una le razze umane, che per lui sono cinque (la bianca, la gialla, la bruna, la rossa e la nera), passando dalla loro descrizione fisica e antropometrica fino a quella caratteriale. Nonostante il carattere scientifico dichiarato, l’opera non è che un insieme di stereotipi, accompagnati da più di 300 incisioni a sostegno delle descrizioni teoriche. Il seminario di Lorella Sini e Marie-France Merger, verte, però, su due aspetti diversi. Se, da un lato, Les races humaines è interessante proprio perché si presenta come un’opera antropologica, in cui si investiga la figura dell’Altro, dall’altro, le due docenti si sono soffermate anche sul rapporto tra l’opera e il traduttore che l’ha tradotta in italiano. L’aspetto interessante è che il traduttore italiano lascia la sua traduzione anonima. Ciononostante, egli ha lasciato dietro di sé delle tracce della sua presenza, soprattutto per quanto riguarda le scelte traduttive, ad esempio non traducendo l’opera nella sua interezza o tralasciando alcune note a piè di pagina. Quindi, sebbene egli faccia parte dei cosiddetti autori invisibili, la sua firma letteraria è rimasta ugualmente impressa nell’opera di arrivo. Lorella Sini e Marie-France Merger hanno sottolineato, in maniera più ottimistica, lo stesso punto trattato da Francis Affergan: il traduttore di un’opera ne è, anch’egli, autore e, in quanto tale, riscrive un testo di arrivo che non è più quello di partenza. Per Francis Affergan si tratta di infedeltà, di traduzione di una perdita; per le docenti pisane, invece, di una presenza, anonima, che gioca un ruolo molto più importante di quello che gli viene riconosciuto.
Il ruolo dell’interprete
La traduzione e l’antropologia si toccano anche in un altro modo: attraverso l’interpretariato. Questo avviene in due modi. Da un lato, se si pensa ai primi antropologi, essi avevano bisogno della figura dell’interprete per riuscire a comunicare con la popolazione studiata, mentre, dall’altro, oggi l’interprete è necessario in campi come quello medico quando dottore e paziente parlano lingue diverse. A occuparsi del primo punto è stato Eric Jolly che ci ha parlato di Marcel Griaule e del suo rapporto con la figura dell’interprete. Marcel Griaule è stato un etnologo francese che tra il 1931 e il 1946 ha compiuto diverse spedizioni in Africa al fine di studiare la cosmogonia dei Dogon, una popolazione originaria del Mali. Griaule viaggiava accompagnato dal suo interprete, Ambara Dolo. L’aiuto della figura dell’interprete durante il periodo coloniale non era una casualità. Questa collaborazione era necessaria in quanto gli etnografi non possedevano quasi alcuna padronanza delle lingue africane, oltre al fatto che non esisteva nessun dizionario né una grammatica che potesse aiutarli. Gli etnografi quindi dipendevano totalmente dai loro interpreti. Il rapporto tra etnologo e interprete, però, si fondava su strane basi. L’interprete, infatti, pur di mostrare le sue capacità ed entrare così nelle grazie dell’etnografo, nascondeva le proprie carenze nelle lingue europee, inventando termini e dando informazioni fittizie, cioè spesso dicendo agli etnografi quello che loro volevano o speravano di sentirsi dire. L’interprete, poi, non svolgeva solo questa funzione, ma contribuiva direttamente al lavoro dell’etnologo, intervenendo, facendo osservazioni e domande. Questo avveniva nel passato. Quanto sono cambiate le cose oggi?
Lo possiamo scoprire attraverso Natacha Niemants che ha affrontato il secondo punto: il ruolo dell’interprete in campo medico. In questo contesto, la figura dell’interprete diventa necessaria quando i pazienti stranieri non parlano bene o per niente la lingua italiana. La docente ci parla nello specifico del campo dell’ostetricia, in cui le donne che si occupano della comunicazione tra medico e paziente devono essere allo stesso tempo interpreti e possedere delle nozioni di ostetrica di base. Natacha Niemants si occupa di osservare e studiare come queste interpreti/ostetriche entrano in contatto con le pazienti, cercando di capire le regole che si celano dietro un ruolo dai margini non ben definiti. Avendo a che fare con pazienti illetterate che spesso non hanno mai fatto una visita, le interpreti tendono a esplicitare cose che per loro potrebbero non essere ovvie. Un aspetto interessante è che queste donne non sono laureate, non sono quindi delle ostetriche a tutti gli effetti. Ciò fa sì che se, da un lato, alcune libertà legate al mestiere del medico sono da loro negate, dall’altro, vista la routine del loro lavoro riescono ad anticipare le domande del medico e, soprattutto, essendo più libere da un punto di vista deontologico, riescono a comunicare con le pazienti trovando il giusto approccio e i giusti mezzi. Il loro modo di approcciare le pazienti non sembra essere diverso, nella sostanza, da quello degli interpreti degli etnologi del ’900. Entrambe le figure svolgono un’attività che va al di là della traduzione, interpretano e si prendono libertà non concesse. In fondo, questo è quello che accade quando si cerca di capire l’Altro: tutto si espande nella ricerca della comprensione.
Superamento delle proprie categorie mentali
Antropologia e traduzione rappresentano l’apertura all’Altro per antonomasia. Nel momento in cui i loro confini si intrecciano in modo ancora più netto di quanto non sia già, ciò che ne consegue è un superamento delle regole prestabilite. La mente si allarga, i limiti delle proprie convinzioni vengono abbattuti e il nostro modo di concepire sia l’una che l’altra disciplina viene messo in bilico.
Il ricercatore che più di tutti ha voluto sfidare le nostre concezioni è stato Simone Ghiaroni, che ha proiettato una serie di frasi che di primo acchito potevano sembrare dei nonsensi, o delle metafore:
Siamo arara rossi
I gemelli sono uccelli
La prima frase è un’affermazione dei Bororo, un gruppo etnico del Brasile; mentre la seconda dei Nuer, una confederazione di tribù che si trova nel Sudan del Sud e nella zona occidentale dell’Etiopia. Entrambe queste affermazioni non sono, quindi, nonsensi, ma, sorprendentemente (per chiunque non condivida la loro stessa cultura), non sono neanche metafore. La seconda frase, I gemelli sono uccelli, viene spesso utilizzata come esempio per chiarire un fenomeno che gli antropologi devono affrontare quando devono spiegare un’immagine dell’alterità. Infatti, quando Evans-Pritchard presentò questa frase al lettore occidentale, al fine di superarne l’apparente incoerenza, dovette compiere un lavoro di traduzione o di esplicitazione di categorie estranee, appartenenti all’altra cultura[2]. Questa strategia contestualizzante viene adoperata da molti antropologi nel momento in cui una cultura B presenta elementi inizialmente incoerenti per gli appartenenti a una cultura A.
Partendo da questi presupposti, Simone Ghiaroni arriva alla conclusione che la giusta traduzione esiste solo se si tiene in considerazione il contesto. Quello che il professore tenta di fare è sfidare la nostra visione del mondo, cercando di destabilizzare, per un attimo, le nostre categorie mentali. A questo punto, citando Eduardo Viveiros de Castro[3], il professore ci domanda: «Qu’arrive-t-il lorsque l’on prend la pensée indigène au sérieux?». Ebbene, quando il pensiero indigeno viene preso sul serio, e solo allora, possiamo azzardare una traduzione. Tradurre l’Altro significa, quindi, prenderlo sul serio, conoscerlo e accettarlo, senza cercare di adattare le sue categorie mentali alle nostre. Il nostro approccio all’Altro, però, deve essere sempre lo stesso? O dovrebbe cambiare a seconda della storia che gli appartiene? Per Alexis Nouss prima di trasporre la storia del migrante, il traduttore deve saper distinguere tra lo straniero e l’esiliato, che vivono condizioni estremamente diverse. La loro differenza maggiore è il rapporto che essi intessono con spazialità e temporalità. Infatti, mentre lo straniero prova una rottura tra il dentro e il fuori, l’esiliato interagisce con questi due opposti in maniera diversa, vivendoli in una sorta di continuità. Ciò accade perché egli non ha lasciato niente dietro di sé, non c’è nulla del suo passato a cui vuole aggrapparsi. Inoltre, mentre lo straniero riesce a vedere una differenza tra ici e là-bas, l’esiliato riconosce solo il nulle part. Questo non-luogo non è altro che la condition exilique in cui egli vive, ovvero una nuova dimensione. Allo stesso tempo, l’esiliato vive in una sorta di continuità anche il presente e il passato, che in lui non si scindono, a differenza di quanto accade per lo straniero.
Davanti a un quadro del genere, il traduttore, per approcciarsi alla traduzione del racconto dell’esiliato, deve chiedersi quale sarà il suo destino e, per capirlo, dovrà lasciare che quest’ultimo racconti il suo percorso, la sua storia, che ricostruisca, insomma, la sua identità tramite la narrazione.
Secondo Alexis Nouss, tradurre il migrante significa tradurre l’intraducibile e la temporalità, in quanto egli viene da nulle-part, è quindi circondato dal mistero, dal segreto, e, nel momento dell’atto traduttivo, si mette a confronto non solo la differenza tra le due lingue, ma anche la distanza temporale tra i due testi. Alla fine del seminario, il docente arriva a due conclusioni. La prima è che, per tradurre il migrante occorre anche tradurre l’opacità, l’oscurità del suo racconto. La seconda, invece, è che tradurlo significa minare la sua identità. Questo avviene perché essa si perde nelle voragini delle lingue, proprio come i migranti si perdono nelle voragini del mare.
Quanto affermato da Alexis Nouss viene confermato da un esempio di vita reale di Mathilde Fontanet. La docente ginevrina ci ha parlato della sua esperienza in quanto scrittrice di un’opera che potremmo facilmente etichettare come postcoloniale, Sous les étoiles du Rwanda (2007). Si tratta di una testimonianza del genocidio ruandese, raccontatale da Odette Habiyakare, un’insegnante sopravvissuta al genocidio. Come si può intuire, il romanzo è intriso di pathos, ma in quest’occasione la scrittrice dell’opera si è soffermata a descrivere soprattutto l’aspetto linguistico che lo compone. Dietro la stesura del romanzo, infatti, si nasconde un doppio lavoro da parte della scrittrice. In effetti, la prima stesura del romanzo era completamente diversa da quella definitiva e che troviamo ancora oggi in vendita. Mathilde Fontanet, dinanzi a una donna ruandese che non parlava il francese di Francia, aveva optato per una scrittura piuttosto sperimentale, che si ribellasse alla lingua normata. Nel momento in cui, però, ha consegnato l’opera a Odette Habiyakare e alla sua editrice, entrambe hanno criticato questa scelta, sentendola poco naturale. Odette Habiyakare, infatti, nonostante non parlasse un francese standard, si sentiva rappresentata da una lingua più neutra. Per questo motivo l’insegnante ginevrina si è vista costretta a riscrivere il romanzo, utilizzando questa volta un francese standard, che compiacesse di più il gusto della sua editrice, ma anche l’identità linguistica di Odette Habiyakare. L’esperienza di Mathilde Fontanet è un chiaro esempio di quanto affermato dal professor Alexis Nouss. Nella prima stesura della sua traduzione, la traduttrice aveva minato oltremodo l’identità di Odette Habiyakare. Sentendosi tradita, quest’ultima ha dovuto ribadire che non si sentiva rappresentata da un’estraneità linguistica, è il suo racconto che è estraneo agli occhi di un occidentale contemporaneo che non ha vissuto sulla propria pelle la parola genocidio.
La lingua non esiste solo in quanto tale. Essa si inserisce sempre all’interno di un sistema culturale, ed esprime le usanze che gli appartengono. Allo stesso modo, una popolazione non può essere studiata senza tenere in considerazione il suo modo di esprimersi. Traduttore e antropologo condividono, quindi, le stesse sensibilità e gli stessi doveri e, nel momento in cui attingono conoscenze l’uno dall’altro, sono in grado di superare dogmi e limiti. Concludendo, il messaggio principale trasmesso durante le due giornate della conferenza è quello che il traduttore, così come l’antropologo, rappresentano le ricchezze più importanti per una società. Doti come mantenere la mente aperta e cercare di superare dettami che appaiono ridicoli davanti alla varietà delle lingue, degli usi e dei costumi, accogliendo ciò che è diverso, sono l’unico modo per evolvere, migliorare e arricchire sempre di più la propria cultura.
Margaret Petrarca
[1]I. Entre traductologie(s) et anthropologie(s) : pratiques théoriques et savoirs disciplinaires
II.Le sens en question : traductions ethnographiques et indexicalité sociale
III.Histoire des traductions et réécritures de l’altérité
IV.Anthropologie des traductions et analyse des discours
[2]In questo caso la frase diventa comprensibile tenendo conto della natura quasi divina condivisa da gemelli e uccelli secondo i Nuer.
[3] In Métaphysiques cannibales: Lignes d’anthropologie post-structurale, 2009, p. 166.