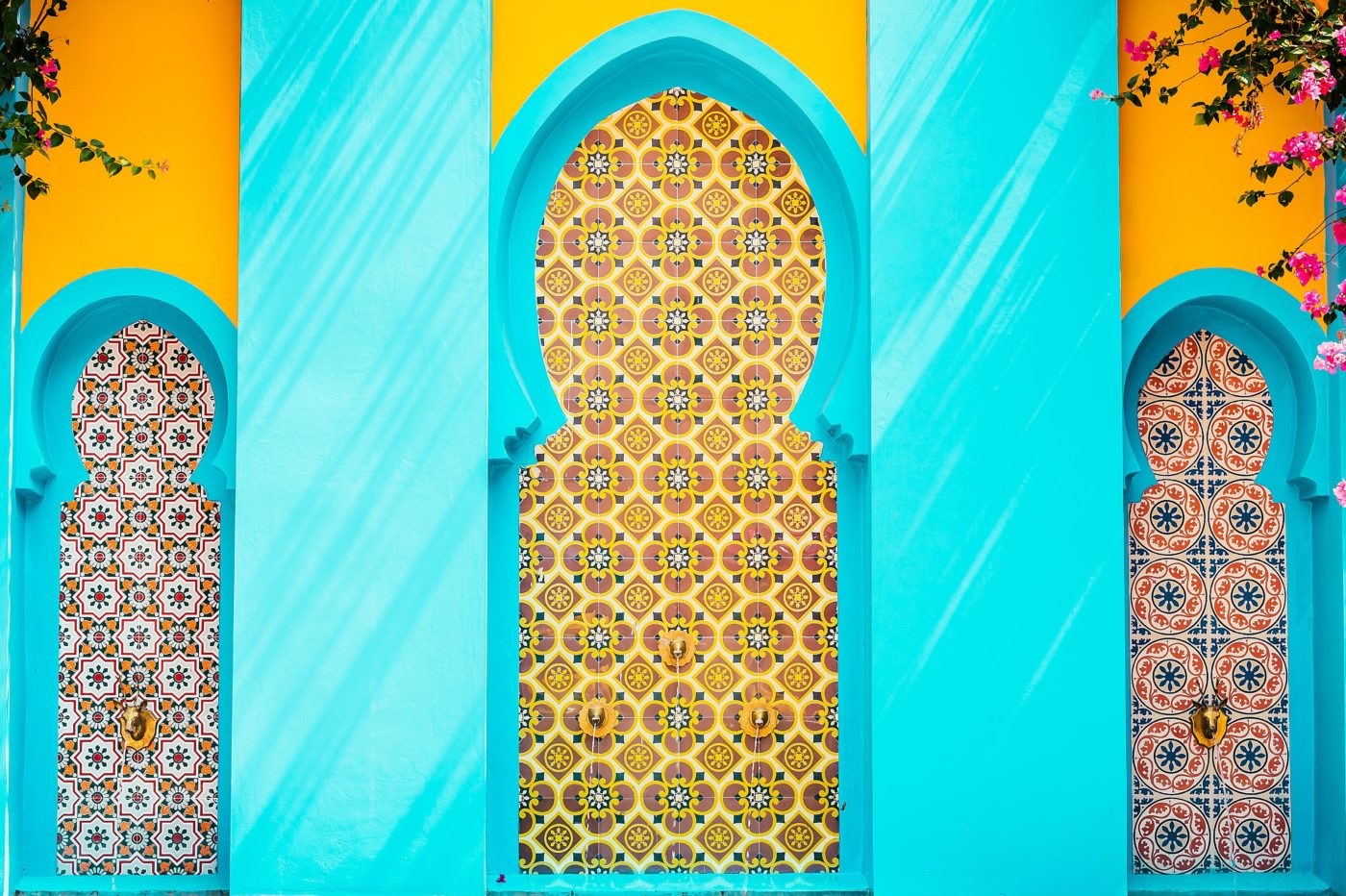Dio ha creato diversa l’umanità perché gli uni e gli altri si conoscano e si aiutino reciprocamente. Non fa differenze fra il bianco e il nero, fra lo straniero e l’autoctono, fra quelli di qui e quelli di laggiù.
 Il matrimonio di piacere è stato pubblicato in Italia nel 2016 da La nave di Teseo. L’autore è Tahar Ben Jelloun, nato a Fès, in Marocco, nel 1944. Oggi vive a Parigi. Poeta, romanziere e giornalista, ha vinto il Premio Goncourt nel 1987. È noto in Italia per i suoi numerosi libri, soprattutto per Il razzismo spiegato a mia figlia (1998), Il libro del buio (2001, vincitore dell’International IMPAC Dublin Literary Award 2004), L’Islam spiegato ai nostri figli (2001).
Il matrimonio di piacere è stato pubblicato in Italia nel 2016 da La nave di Teseo. L’autore è Tahar Ben Jelloun, nato a Fès, in Marocco, nel 1944. Oggi vive a Parigi. Poeta, romanziere e giornalista, ha vinto il Premio Goncourt nel 1987. È noto in Italia per i suoi numerosi libri, soprattutto per Il razzismo spiegato a mia figlia (1998), Il libro del buio (2001, vincitore dell’International IMPAC Dublin Literary Award 2004), L’Islam spiegato ai nostri figli (2001).
Riassunto
A Fès un narratore di nome Goha racconta la storia d’amore tra Amir, un commerciante della città, e Nabou, una giovane fulana del Senegal con cui l’uomo contrae ogni anno un “matrimonio di piacere”. Infatti, anche se Amir è sposato con Lalla Fatma, gli è permesso sposarsi per un periodo di breve durata quando si reca in Senegal per motivi di lavoro. In uno dei suoi ultimi viaggi in Senegal, Amir decide di portare con sé a Fès Nabou, nonostante le titubanze del figlio Karim che teme la reazione della madre, che mai avrebbe accettato l’arrivo di una donna nera quale innamorata del marito in casa propria. Lalla Fatma, infatti, inizia fin da subito a trattare male Nabou, ricoprendola di insulti razzisti e facendola dormire con le domestiche. Amir, per poter vivere a pieno la sua relazione con Nabou, non ha altra soluzione che sposarla ufficialmente, in quanto, essendo un uomo musulmano, ha diritto a sposare fino a quattro donne. Dopo poco il matrimonio, Nabou resta incinta di due gemelli, uno bianco, Houcine, e uno nero, Hassan.
Lalla Fatma muore, mentre in Marocco gli assetti politici ed economici cambiano con l’avvicinarsi dell’Indipendenza. Per via di questi cambiamenti, Amir è costretto a trasferirsi a Tangeri, portando con sé Nabou, Karim e i due gemelli. Alla morte di Amir, segue la bella notizia della nascita di Salim, il figlio di Hassan, praticamente abbandonato dalla madre. Quando Salim è ormai ventenne, si reca a Saddam, un quartiere malfamato e povero di Tangeri, con l’intenzione di scattare delle fotografie. Lì, però, è scambiato per un clandestino e viene mandato in Senegal. Una volta a Dakar, il ragazzo si ambienta subito, ma, dopo la sua avventura qualcosa è cambiato in lui. Salim, infatti, sente di essere un migrante, unica condizione che gli permette di ritrovare la sua identità. Per questo motivo, parte con un gruppo di altri migranti sperando di arrivare in Europa. Dopo un lungo viaggio i ragazzi arrivano a Tangeri, dove sono costretti a restare, perché non c’è alcun barcone ad attenderli. Salim, rimasto tutto il giorno in un bar, viene poi recuperato dalla famiglia. Pian piano la vita ritorna alla normalità, anche se Salim continua a non sentirsi al proprio posto. Per questo, tenta ancora una volta il viaggio verso l’Europa, finendo per essere ucciso da un poliziotto a Ceuta.
La Storia: dall’Indipendenza del Marocco ai flussi migratori odierni
Come in ogni romanzo postcoloniale che si rispetti, Tahar Ben Jelloun utilizza le vicende della famiglia di Amir per raccontare la storia del Marocco. Il suo racconto, passando di generazione in generazione, parte da pochi anni prima dell’Indipendenza del Paese fino al 2010. I riferimenti alla colonizzazione sono molti all’interno del romanzo, e non si limitano a quella marocchina. Tahar Ben Jelloun, oltre alla colonizzazione francese e spagnola in Marocco, denuncia anche quella francese in Tunisia, in Algeria e in Senegal.
Il Marocco si era fatto sfruttare dalla Francia all’epoca del protettorato. L’Algeria non le bastava più, nemmeno la Tunisia, doveva avere anche il nostro paese! Povero Marocco! (p. 12)
La colonizzazione francese in Marocco ebbe ufficialmente inizio nel 1912, quando col Trattato di Fez viene stabilito il Protettorato francese del Marocco. Ovviamente questo portò a una serie di rivolte, sempre soffocate dalla Francia. Nel 1943 venne fondato il partito nazionalista Istiqlal, che puntava all’indipendenza marocchina. Con l’aiuto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, Istiqulal riuscì a ottenere l’indipendenza del Marocco nel 1956 a eccezione di alcune città (Tarfaya divenne indipendente nel 1958 e Sidi Ifni nel 1969), anche perché la Francia era ormai indebolita a causa della Seconda guerra mondiale e delle crisi nelle colonie in Algeria e in Indocina.
Tahar Ben Jelloun ci racconta del processo d’indipendenza del Marocco attraverso le preoccupazioni di Ghazouani, un commerciante di Fès che esprime ad Amir la sua inquietudine nei confronti dei gruppi nazionalisti che stavano reclamando l’indipendenza del Paese. Ghazouani infatti è preoccupato per il suo commercio, mentre Amir si mostra subito a favore dei moti indipendentisti. Amir ricorda anche del “decreto berbero”, il dahir berbère, del 1930, che prevedeva una distinzione tra arabi e berberi, distinzione mai esistita né prima né dopo di allora. L’obiettivo della Francia era dividere il Paese, che all’epoca era a maggioranza berbera. In quegli anni Amir aveva partecipato con il padre a una manifestazione contro il decreto, così come nel 1947 aveva aderito al partito Istiqlal.
Tahar Ben Jelloun, che estende l’ambientazione del romanzo fino ai giorni nostri, ci racconta anche di un altro fenomeno che ha segnato il suo Paese, e che, oggi più che mai, è al centro della scena mediatica italiana: la migrazione umana. L’autore ci parla di Tangeri, dove
l’arrivo improvviso dei giovani subsahariani che avevano fallito nella loro traversata verso l’Europa aveva modificato il volto e il corpo della città. (p. 162)
Il Marocco, vicinissimo alla Spagna, è una terra di passaggio per tutti quei migranti che cercano di fare la loro traversata per l’Europa. Tahar Ben Jelloun ci racconta di queste persone quasi come fossero in pellegrinaggio: la speranza di ricompensare la fatica del viaggio con un’illuminazione nella propria vita. Molti, però, non riescono a salpare, restando confinati a Tangeri, in un Paese che non è il loro. La clandestinità e la povertà impediscono loro di inserirsi nella società marocchina, ed è per questo che l’autore ci parla del quartiere Saddam di Tangeri, nome datogli in ricordo di Saddam Houssein, che non è assoggettato alle leggi della città, ma alle proprie: delinquenza, droga e prostituzione. Il tassista che porta Salim a Saddam, parlando dei clandestini che risiedono nel quartiere, dice «che avrebbero fatto meglio a ripartire verso la loro giungla perché il Marocco ha già abbastanza problemi coi marocchini e non può accogliere tutti i disperati della terra…» (p. 172). Vi ricorda qualcosa?
La schiavitù
Tahar Ben Jelloun si sofferma anche su una parte di storia che ha portato tanta sofferenza al continente africano: la schiavitù. Non parla tanto della tratta degli schiavi messa in piedi dagli europei, ma denuncia il suo stesso Paese. Il Marocco si è infatti macchiato di questo terribile crimine nei confronti di persone provenienti dalle regioni subsahariane o dalle campagne delle sue stesse terre.
La schiavitù era naturale. […] I primi schiavi erano arrivati in Marocco grazie ai commerci che gli abitanti di Fès più intraprendenti avevano coi paesi africani vicini. Sebbene condividessero lo stesso continente, gli abitanti di Fès erano lungi dal considerarsi africani. Gli abitanti di Fès erano bianchi, dunque superiori ai neri, qualunque fosse la loro provenienza. (p.16)
Più volte l’autore, attraverso il punto di vista di Amir, racconta della schiavitù imposta alle regioni subsahariane dai marocchini. Quando il commerciante porta con sé in Senegal Karim, gli dice di portare rispetto a quelle genti che hanno tanto sofferto a causa loro. Se questo moto di rispetto scatta nei confronti dei senegalesi, lo stesso non accade per le domestiche che vivono nella sua casa a Fès: la loro condizione era talmente normalizzata che nessuno la percepiva come ingiusta e discriminatoria.
La gente di campagna non li amava. Spesso le loro donne o le loro figlie lavoravano come domestiche presso le famiglie di Fès. La situazione assomigliava a una forma di schiavitù, ma non scandalizzava nessuno. (p. 82)
Il razzismo
Tahar Ben Jelloun scrive di una scena discriminatoria molto complessa: al razzismo degli europei nei confronti degli africani, si aggiungono quello degli africani bianchi verso gli africani neri, e quello dei neri nei confronti dei bianchi. La situazione descritta, articolata e pungente, mette in scena una realtà complessa ma reale, mostrando come il popolo marocchino, vittima del colonialismo francese, sia diventato esso stesso carnefice di persone che vivono nel proprio continente. Inoltre, l’autore non parla dei neri semplicemente come vittime, rasentando come spesso accade il “mito del buon selvaggio” di Rousseau. Al contrario, dimostra quanto i pregiudizi e la diffidenza si sia irradiata nella mente dei neri nei confronti dei bianchi. Quando Nabou decide di partire per Fès assieme ad Amir, il fratello la mette in guardia:
Non ti dirò mai abbastanza quanto devi diffidare dei bianchi […] ci lamentiamo del razzismo dei bianchi nei nostri confronti… È vero; sono razzisti, colonialisti, arroganti e umilianti. Ma sappi una cosa: nemmeno noi li amiamo. Anche noi siamo razzisti, è normale, non baciamo i loro piedi… Solo che noi non abbiamo i mezzi per andare a colonizzarli (p. 57)
Il personaggio che più di tutti manifesta un razzismo esacerbante è Lalla Fatma nei confronti di Nabou. Già convinta di essere superiore ai neri in quanto bianca, convinzione diffusa tra tutti gli abitanti di Fès, la gelosia nei confronti del marito la rende un personaggio cattivo, capace di proferire solo parole d’odio.
Mai nella vita sopporterò di essere soppiantata da una negra, una sporca straniera che non sa neanche parlare […] Quelle sono persone selvagge che ci detestano perché Dio ci ha fatti bianchi e puliti mentre loro sono i rifiuti dell’umanità. (p. 115)
Se il razzismo di Lalla Fatma affonda le sue radici in pregiudizi e stereotipi, come l’odore non piacevole dei neri, Nabou, parlando con Hassan dice:
Sai cosa mi diceva mio padre? Diceva che i bianchi hanno l’odore dei cadaveri! Ti rendi conto? Quindi tu puzzeresti di sudore, ma tuo fratello bianco di morto! (p. 195)
I padre di Lalla Fatma, ad ogni modo, resta esterrefatto dalle tante brutte parole della figlia e le dice che si sta comportando come una persona indegna della religione musulmana. Infatti, come Amir ricorda a un carovaniere «Dio ha creato diversa l’umanità perché gli uni e gli altri si conoscano e si aiutino reciprocamente. Non fa differenze fra il bianco e il nero, fra lo straniero e l’autoctono, fra quelli di qui e quelli di laggiù» (p. 62).
La questione identitaria
La questione identitaria nel romanzo passa soprattutto attraverso Hassan e suo figlio Salim. Hassan, nero, gemello di Houcine, bianco, per via del colore della sua pelle deve affrontare difficoltà maggiori rispetto al fratello. Il colore della sua pelle gli pare essere in contrasto con la sua vita. Figlio di un commerciante bianco e benestante, non sa se considerarsi africano o marocchino, dal momento che a Fès «I marocchini non si sentono africani perché hanno la pelle bianca» (p. 47). Durante la sua adolescenza, Hassan fa la conoscenza di Jim, un nero che insegna in una scuola americana. Jim si considera allo stesso tempo sia africano che americano, facendogli capire che anche lui può sentirsi sia africano che marocchino. Nonostante questo, Hassan continua a essere «ossessionato dalle sue origini, dal colore della sua pelle» (p. 153), sentendosi vicino al quartiere di Saddam, in cui poteva essere un «nero fra i neri» (p. 167). Eppure, dentro di lui sente il contrasto tra la vita da clandestino che avrebbe potuto vivre in quel quartiere malfamato e quella sofisticata a cui invece più volte è stato messo di fronte. In un certo senso, sente di appartenere a entrambi i mondi, o forse a nessuno dei due.
Dov’era il suo posto? Chi era? (p. 170)
Se a un certo punto Hassan è convinto che «La mia pelle è nera. Decisamente nera […] Io sono africano […] sono un clandestino, il clandestino capo, so da dove vengo ma non so dove vado…» (p. 171), la realtà è che, come gli dice un ciarlatano, che forse tanto ciarlatano non è, «Tu non sei un vero nero, hai una maschera bianca, si vede da lontano» (p. 171). Quest’affermazione subito porta alla mente Frantz Fanon e la sua opera Pelle nera, maschere bianche (1952), in cui l’autore spiega come il colonialismo abbia creato una nevrosi collettiva in cui i neri si sentono inferiori ai bianchi. Attraverso le parole del ciarlatano, dobbiamo pensare che Hassan, nero, sia in realtà affascinato dai bianchi al punto di voler essere uno di loro? E dal momento che il fratello gemello è bianco, e che ha vissuto in Marocco come un bianco, si sente davvero bianco anche lui? Del resto, Hassan ha conosciuto il colonialismo: ne è anche lui una vittima?
La risposta potrebbe essere un sì, dal momento che il figlio, Salim, nero come il padre, è quello che tra i due accetta a pieno la sua négritude. Salim, infatti, nonostante non abbia problemi economici, preferisce vivere come un clandestino e provare a migrare in Europa con i suoi fratelli subsahariani. Prima di arrivare a questo punto, però, anche Salim si interroga sulla sua identità, che ritrova solo quando diventa un migrante. Infatti, una volta spedito in Senegal, il narratore afferma che Salim «abitava per la prima volta il colore della sua pelle» (p. 175) e che «Il colore della sua pelle era diventato la sua sola identità» (p. 216). Lo stesso Salim, che racconta in prima persona della sua migrazione, afferma:
Nera, assolutamente nera, la mia pelle era nera fino ai piedi, come se li avessi colorati con inchiostro di Cina. Anche i palmi delle mie mani. Non c’era più nessuna ambiguità ora. Ero totalmente nero. […] La mia pelle nera era la mia identità, doppia, tripla, meticcia, torbida, pallida, bruciante e perfino infernale. (pp. 211-212)
Secondo Alexis Nouss, l’esiliato vive la spazialità e la temporalità in una sorta di continuità, dal momento che rinnega sia l’una che l’altra. L’esiliato, infatti, riconosce solo il nulle part. Questo non-luogo non è altro che la condition exilique in cui egli vive, ovvero una nuova dimensione, così come non scinde il presente dal passato. In questo senso, l’esiliato non ha più un’identità e, durante la sua migrazione, la stessa cosa sembra accadere anche a Salim, che afferma «vado avanti senza voltarmi su ciò che lascio dietro di me» (p. 185), «sono ridotto a nulla: un’ombra che erra nel deserto» (p. 186), e, riferendosi ai migranti «[si ha] l’impressione di essere persone nuove, senza passato […] il principio è liberarsi di tutto, compreso il proprio nome e la propria storia. Siamo dei ‘senza’: senza identità, senza nome, senza cognome, senza denaro, senza legami, senza famiglia, senza memoria» (p. 189). In realtà, poco dopo lo stesso Salim afferma che ricorda ancora il suo nome, che non ha ancora rinunciato del tutto alla sua identità, e pensando addirittura che «questa prova mi aiuterà a sentirmi a mio agio nella mia pelle» (p. 190).
La questione linguistica
Come per molti romanzi postcoloniali, l’inserzione di altre lingue oltre a quella principale (in questo caso il francese, poi tradotto in italiano) si manifesta in maniera massiccia nel testo. Si tratta principalmente di parole in arabo, legate alla questione identitaria. L’estraneità linguistica che queste parole suscitano nel lettore europeo serve a portarlo lontano, nel Paese in cui la vicenda è narrata, ma anche e soprattutto per esprimere l’identità e la cultura dei personaggi. Non è un caso, infatti, che spesso le parole straniere presenti nel testo siano un rimando ai cibi locali (ras el hanout), al vestiario (gandura, burnus, taguia, tchamir, djeballa), alla casa (massyra), alla religione (hamdoullah, haram, adul, tolbas).
È normale che la terminologia impiegata per descrivere aspetti culturali che non esistono nella nostra cultura e di conseguenza nella nostra lingua sia nella lingua della cultura a cui fa riferimento. Oltre a queste parole che si rifanno a cibi, abiti e religione, però, Tahar Ben Jelloun impiega l’arabo anche per descrivere l’identità di alcuni personaggi. Una delle parole in arabo che appare più di frequente nel testo è kahlouch (sinonimo di azzi e abid), «Kahlouch significa “negro”, “schiavo” in arabo» (p. 165), a cui si oppone la parola khoroto «che è il soprannome che si dà ai marocchini bianchi che non hanno successo in nulla». Un’altra parola in arabo per designare l’identità è bidoun, che è il nome che si dà ai migranti che hanno perso la loro identità.
La religione
Tahar Ben Jelloun parla brevemente della religione di Nabou, animista, in cui hanno un’importanza fondamentale gli spiriti degli antenati e i baobab «considerati dagli africani come alberi magici» (p. 47).
A lungo, invece, lo scrittore parla della religione islamica attraverso le vicende dei personaggi. Il romanzo a suo modo getta le basi per conoscere l’islam. L’autore ci parla dei cinque pilastri di questa religione: la professione di fede, la preghiera, l’elemosina, il digiuno nel mese del Ramadan e il pellegrinaggio alla Mecca. Sono due, però, le idee su cui lo scrittore si sofferma maggiormente: da un lato, l’idea che Dio mette sulla strada dell’uomo l’infelicità per metterlo alla prova e, dall’altro, che i musulmani utilizzano l’islam per giustificarsi di cose che in realtà sono contro la religione islamica.
Secondo l’islam, infatti, ogni cosa, seppur autonoma, dipende in principio da Dio. Quindi, ogni evento che accade, anche se triste o doloroso, fa parte del piano di Dio, condotto in vista di un solo fine: il bene dell’umanità intera. Questo dà ai musulmani una grande forza d’animo e una grande capacità di fronteggiare le avversità, cosa che vale anche per tutti i personaggi del romanzo, soprattutto i più fedeli e primo tra tutti Amir.
Amir è il personaggio più credente, ed è un conoscitore esperto dei testi sacri islamici, al punto che il suo modo di vedere le cose è spesso mistico, ponderato e sempre costruito su basi buone e pure. Amir sa, però, che spesso i musulmani non conoscono bene la propria religione come dovrebbero, e così, quando Nabou decide di convertirsi all’islam, le dice:
Non bisogna confondere l’islam coi musulmani. L’importante è avere un comportamento corretto e umano. Colui che maltratta una donna non ha bisogno del pretesto della religione per farlo. Ma so bene che alcuni giustificano le loro brutte azioni appellandosi all’islam. Hanno torto. (p. 43)
Altre tematiche di rilievo
Tahar Ben Jelloun all’interno del romanzo si sofferma anche su altre tematiche. Elencarle tutte necessiterebbe di uno spazio molto grande, per questo mi soffermerò solo su quelle che secondo me hanno più rilievo.
Una delle tematiche più trattate all’interno del libro è quella del viaggio. L’autore si sofferma sul viaggio dal Marocco al Senegal che compiono prima Amir e Karim e poi Salim. Il viaggio che porta verso sud non ha difficoltà. Nel caso di Salim si tratta addirittura di un veloce viaggio in aereo. Quando invece il narratore racconta del viaggio di Amir, Karim e Nabou e di quello di Salim per risalire dal Senegal al Marocco, le avversità sono numerose e il viaggio si dilata molto nel tempo. Amir, Karim e Nabou affrontano diversi djin, entità maligne, e problemi con l’autobus che deve portarli a Fès. Invece, il primo viaggio di Salim è così lungo e stancante che sembra quasi un pellegrinaggio, mentre il secondo gli costerà addirittura la vita. Del resto, come dice Salim, «più si sale verso nord e più questa ospitalità si riduce». (p. 191)
L’altra grande tematica è la magia. Sebbene nel romanzo si parli di stregoni e vecchi saggi, il personaggio che più di tutti ha un rapporto intenso con la magia è Lalla Fatma. La donna, infatti, si rivolge a un mago quando Nabou entra in casa. Il suo obiettivo è quella di farla allontanare e, quando la giovane donna resta incinta, di farle perdere i bambini. Per farlo, il mago le dà talismani e pronuncia formule magiche di vario tipo che, però, non sortiscono alcun effetto.
Infine, un’importanza notevole ha anche la sessualità. Le pagine in cui si parla dell’erotismo tra Nabou e Amir sono molte, sebbene Tahar Ben Jelloun non entri mai nel dettaglio delle loro pratiche. Il messaggio però è chiaro: tra i due c’è una passione vorace, che manca assolutamente con Lalla Fatma. Il razzismo si spinge fin nella sfera sessuale, tanto che più volte nel libro si accenna alla focosità delle donne nere, contro l’inibizione delle donne bianche. Solo in un momento Lalla Fatma si spinge oltre, prendendo in bocca il pene del marito. Dietro questa sua disinibizione si nascondono i suggerimenti di Samra, una donna divorziata che dispensa consigli sul sesso e sul cibo all’hammam. Questa dice alle altre donne di vivere il sesso con più libertà, precisando che se le donne nere sono più libere è perché «non hanno il freno della religione» (p. 102).
Margaret Petrarca
Per acquistare il libro: